|
Pubblicata il 27/04/2004
Le nostre unicità
Cari Amici, reduci dalla
manifestazione di Grottammare del 17/18 aprile, possiamo finalmente
fornirvi i necessari aggiornamenti in relazione alle sperimentazioni
che eseguite intorno al caso della cella di Mizuno/Ohmori o Naudin
che a dir si voglia.
Innanzitutto bisogna precisare subito che la cella, nel prosieguo
delle sperimentazioni, ha subito una serie di trasformazioni che l’hanno
completamente mutata rispetto al progetto originario, offrendo delle
unicita’ molto peculiari che hanno permesso, tra l’altro,
di ottenere un quadro fenomenologico- teorico completamente nuovo.
Una prima fondamentale
differenza rispetto alla cella Mizuno/Ohmori, non abbiamo utilizzato
un anodo di acciaio inox per evitare la possibilità che impurità
di sorta potessero inquinare le misure ma abbiamo preferito utilizzarne
uno che fosse anch’esso di tungsteno, evitando di incappare
in sviste provocate dai depositi che l’acciaio poteva rilasciare
galvanicamente sul catodo. Di questo fatto avevamo gia’ fornito
sufficienti ragguagli poiche’ nel primo resoconto su questo
sito cominciammo l’esperienza utilizzando questo materiale quasi
da subito.
Per quanto riguarda la
soluzione alcalina adoperata, così come scelto dall’inizio,
e’ stata largamente utilizzata una soluzione di carbonato di
potassio molto puro e testandola a diverse concentrazioni. Prima di
scegliere definitivamente il carbonato di potassio come soluzione
ottimale, il nostro gruppo ha comunque effettuato esperimenti anche
con soluzioni a pH acido e sono stati sperimentati cationi diversi
come il magnesio, il litio e il sodio. Utilizzando questi differenti
cationi, il plasma prodotto nella cella ha presentato colorazioni
caratteristiche e comportamenti leggermente diversi a seconda del
tipo di catione utilizzato. Lo studio del comportamento del plasma
attraverso elettrolisi con altri cationi, ci ha permesso di capire
con maggior dettaglio i fenomeni in gioco e ci ha offerto l’opportunita’
di avvalorare meglio le nostre tesi che mostreremo in questo articolo.
 |
| Analisi al SEM con evidenza di
Osmio |
Riteniamo che la scelta
di adoperare un anodo di tungsteno al posto dell’acciaio sia
stata fondamentale. Grazie a tale soluzione non abbiamo misurato sul
catodo i depositi di ferro, cromo e carbonio indicati dagli scienziati
nipponici. Ma, di contro, come vedremo si sono verificate presenze
di renio, itterbio, osmio, tulio e anche oro.
Queste verifiche sono state effettuate tramite microscopio elettronico
a scansione, grazie alla gentile collaborazione di amici che, lavorando
presso universita’ locali, avevano la strumentazione adatta
a tale scopo.
Nel prosieguo delle prove
abbiamo configurato la zona intorno al plasma mediante una particolare
geometria catodica che ci ha consentito di ottenere zone con una densita’
di corrente molto elevata. Chiameremo questa zona “banda
di reazione”. In alcune prove, proprio su tale
zona, abbiamo stimato una densita’ di corrente oltre i 10 A/cm2.
Il fatto di riscaldare
inizialmente la soluzione elettrolitica è fondamentale poiche’
tale operazione offre le giuste condizioni di conducibilita’
elettrica, necessarie per un corretto innesco del plasma e soprattutto
per lo stabilirsi di un caratteristico transito ionico.
La teoria con le possibili
reazioni nucleari
Dopo notti insonni e discussioni
interminabili, finalmente, dopo l’ennesima birra consumata in
estenuanti brain storming ecco quale potrebbe essere il modello che
spiega il funzionamento della cella.
Tutto inizia grazie al
riscaldamento graduale della parte dell’elettrodo catodico immerso
in soluzione. Tale riscaldamento, inizialmente generato per effetto
Joule, diventa di entità notevole quando, nel caratteristico
istante critico, si innesca il plasma. Tale istante critico, che dipende
dalla temperatura della soluzione e dalla tensione applicata alla
cella, si verifica quando le bolle di idrogeno gassoso sono troppo
numerose e creano isolamento galvanico fra la soluzione e il catodo.
In quel momento gli ioni di potassio positivi che hanno avvinto tutta
la superficie catodica come uno schermo, innescano delle scariche
elettriche che decretano l’inizio dell’azione di plasma.
Il radiometro infatti, fornisce in questa fase indicazioni caratteristiche
di tale meccanismo. Successivamente il plasma circonda il catodo aumentandone
la temperatura della parte immersa. Mentre questo accade i protoni
provenienti dalla soluzione elettrolitica cominciano a scaricarsi
nella zona alta del plasma: la “banda di reazione”.
Diciamo subito che questo
meccanismo di generazione di plama porta il tungsteno, piu’
o meno velocemente, ad assumere una temperatura che raggiunge punte
di oltre 3000 gradi; il raggiungimento di tale temperatura è
comprovato dalle foto al microscopio che illustrano chiaramente le
zone di fusione del metallo. Ed è noto che il tungsteno fonde
a circa 3400°C.
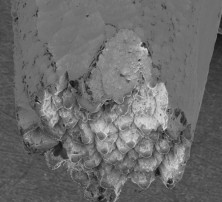 |
| Punta catodo tungsteno in evidente
fusione |
Il tungsteno,
portato a tali temperature, risulta essere anche sede di una intensa
emissione di elettroni termoionici. Inoltre, la geometria catodica
peculiare che abbiamo introdotto costringe il flusso di ioni di idrogeno
(protoni), presenti nella soluzione, a concentrarsi in una particolare
area del catodo di tungsteno. Un altro importantissimo effetto è
generato dagli ioni di potassio della soluzione elettrolitica che,
circondando il catodo, creano l’armatura positiva di un condensatore
virtuale e un conseguente effetto catalizzante particolare per le
reazioni che fra poco enumereremo.
Dopo vari aggiustamenti
e verifiche, il gioco funziona più o meno così: grazie
allo stato coerente di plasma e all’enorme numero di elettroni
presenti in esso e grazie all’ “effetto condensatore”
dovuto al catione alcalino che non si deposita al catodo, capita che,
di tanto in tanto, qualche elettrone invece di unirsi ad un protone
per formare un atomo di idrogeno, vi ci vada a sbattere contro, generando
un neutrone secondo la reazione:
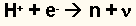
o identicamente
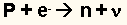
Il simbolo del neutrino
è stato posto in previsione di una ipotetica necessita’
di riequilibrare eventualmente l’energia ma, per ora, si tratta
di un’ipotesi. Potrebbe anche verificarsi un tipo di reazione
completamente diversa ma, per quanto riguarda i neutroni, essi vengono
prodotti certamente. Siamo molto consci di quello che stiamo affermando,
così come sappiamo che questa reazione, nell’ottica dell’attuale
paradigma, e’ una reazione nucleare molto improbabile, oppure
al massimo, ottenibile mediante una grande quantita’ di energia.
Tuttavia siamo abbastanza sicuri che, facendo lavorare il plasma in
determinate condizioni, nella zona da noi chiamata banda di reazione
vengono prodotti numerosi neutroni. Una volta generati capita che
qualcuno di essi penetri nel nucleo di un atomo di tungsteno accrescendone
il numero di massa:
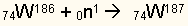
Non sappiamo se a tale
processo partecipa piu’ facilmente, in modo particolare, uno
dei 5 isotopi naturali del tungsteno (e’ probabile), in ogni
caso il risultato che si ottiene introducendo neutroni nel nucleo
è che il numero di massa dell’elemento aumenta e con
esso aumenta anche l’instabilità dell’edificio
nucleare. Di conseguenza anche nel nostro caso, iterando il processo,
si ottiene un nucleo di tungsteno instabile. La stabilità del
nucleo viene ristabilita tramite il decadimento di un neutrone che
emette un elettrone beta, lasciando un protone nel nucleo. E quando
appare un nuovo protone nel nucleo possiamo certamente affermare che
l’atomo originario non è più tungsteno:
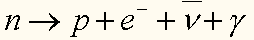
(la notazione  oppure oppure
 e’ equivalente) e’ equivalente)
In questo modo, e per catture
neutroniche successive , è spiegabile la presenza di tutti
gli altri elementi e, contemporaneamente, la cella produce energia.
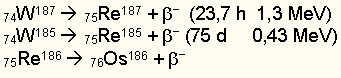
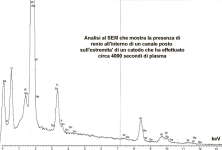 |
Analisi al
SEM con evidenze di Renio |
Intanto, per
giustificare la presenza dei nuclidi che precedono il tungsteno e
che sono presenti sull’elettrodo catodico, c’e’
la possibilita’ che si verifichi una particolare sequenza di
catture elettroniche. Qui di seguito viene mostrata una serie di reazioni
conosciute dalla fisica in cui, partendo dal tantalio (elemento che
precede di un posto il tungsteno) si arriva esattamente al tulio attraverso
l’itterbio, entrambi elementi trovati sul catodo:

E’ molto probabile
quindi ipotizzare che, nell’inferno costituito dalla tempesta
elettronica del plasma, alcuni nuclei di tungsteno possano trasformarsi
in tantalio per poi dar vita ai nuclei con numero atomico inferiore.
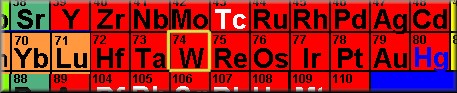
Il fatto che i giapponesi
non abbiano rinvenuto tutto questo è dovuto a una seconda peculiarità
della nostra cella ottenuta mediante l’inserimento di una “camera
di reazione”, da noi inizialmente realizzata per caso,
rivelatasi successivamente la carta vincente per ottenere abbondanza
di nuclidi. Il tutto è basato sul calcolo dell’inviluppo
di tale camera. Quindi c’è anche una configurazione geometrica
sostanziale nella configurazione della cella.
Conclusioni
Appena
sul nostro elettrodo catodico di tungsteno facciamo verificare le
condizioni opportune, riusciamo a sintetizzare nuclidi
normalmente non presenti su di esso. In parole piu’ semplici
operiamo una trasmutazione. Il tungsteno viene trasformato
in renio, oltre che in tulio, osmio, erbio, itterbio e persino oro.
Il renio è l’elemento che, nella tavola periodica, segue
il tungsteno, e così pure l’osmio e l’oro. Il tulio,
l’erbio e l’itterbio invece lo precedono. Le quantita’
in peso di questi metalli sono irrisorie e proprio nel caso dell’oro
equivalgono a meno di pochi milionesimi di grammo, tuttavia il significato
scientifico di questo risultato e’ notevole.
Per quanto riguarda l’energia
termica prodotta dalla cella, siamo attualmente in grado
di stimarla con maggior precisione rispetto a 5 mesi fa. Giungendo
alla conclusione che i guadagni termici sono molto notevoli. Nelle
oltre 70 prove fino ad ora effettuate abbiamo misurato
diverse volte, prendendo in considerazione solo il riscaldamento e
l’evaporazione dell’acqua, un rendimento del 120%.
Considerando che, solo la stima delle perdite calorimetriche supera
già di suo abbondantemente il 25% dell’ammontare totale
di calore fornito, e stabilito che l’energia in uscita prodotta
dai gas in espansione raggiunge certamente valori ad esso paragonabili,
possiamo dire certamente che la cella ha efficienze ancora più
elevate.
Una nostra ipotesi,
da verificare e comprovare, è che i nucleoni all’interno
del nucleo degli atomi si dispongano in strutture geometriche caratteristiche.
E potrebbe darsi che alcune di queste configurazioni hanno maggiore
attitudine, rispetto ad altre, di reagire ad eventi esterni modificando
gli assetti geometrici. Sono proprio tali aspetti geometrici
che favoriscono l’assorbimento dei neutroni e, successivamente,
trasmutano. Forse il nucleo del tungsteno e’ uno di questi nuclei
caratteristici.
Il nostro
gruppo di Caserta e’ intenzionato a proseguire nella sperimentazione
qualora ricevessimo aiuti economici per esplorare
altri materiali catodici caratteristici e soprattutto altre condizioni
di impianto che saremo molto contenti di suggerire.
A. Dattilo, D. Cirillo, V. Iorio

|

